"Giornata del fiocchetto lilla": dalla sensibilizzazione al vuoto pneumatico
- Rosanna Caraci
- 17 mar
- Tempo di lettura: 6 min
di Rosanna Caraci

Ieri l'altro, 15 marzo, si è celebrata la giornata nazionale del fiocchetto lilla, giornata di informazione e sensibilizzazione contro i disturbi del comportamento alimentare. Una giornata un po' in ombra, inutile negarlo, per la "concorrenza" della manifestazione pro Europa a Roma. A maggior ragione, ci pare giusto ritornare a riflettere su perché anni fa, l'allora presidente della Repubblica Giorgio Napolitano di dare un segno visibile e pubblico di quanto stava accadendo. Il Quirinale lo fece su impulso di Stefano Tavilla, padre di Giulia, una ragazza adolescente morta per le complicazioni da bulimia in attesa di un ricovero in una struttura adeguata. Stefano Tavilla divenne così portabandiera della lotta di famiglie e pazienti che, da anni, reclamano attenzione non solo a parole, ma impegni economici per strutture che possano accogliere in modo adeguato i pazienti e le pazienti, spesso adolescenti, sempre più bambini, che non hanno nemmeno dieci anni e che ingrossano le liste d’attesa degli ospedali pediatrici.
I disturbi alimentari: un male sempre più oscuro
I numeri registrano 3milioni e mezzo di pazienti in tutta Italia, poco più di settecentomila in Piemonte. Numeri che si considerano sottostimati perché naturalmente viene censito chi dal medico o ai centri di salute mentale del territorio o negli ospedali ci è arrivato ed è stato intercettato dalla macchina che fotografa numericamente una situazione che dopo la pandemia è sfuggita di mano.
Il 40 per cento dei casi di esordio dei disturbi del comportamento alimentare in adolescenza continuano in età adulta, e tra i guariti un terzo ricade nell'età adulta. Stando a dati recenti, forniti dall’Ospedale Infantile Regina Margherita, dal 2019 al 2022 i pazienti in età evolutiva in carico a livello ambulatoriale/territoriale sono aumentati del 112%. Tra gli adulti, dopo la pandemia i casi sono saliti dell'80 per cento. Dal 2018 al 2021 l’Ospedale Infantile ha registrato un aumento del 100% degli accessi in urgenza dal Pronto soccorso. Ormai la malattia può esordire anche prima dei 10 anni di età.
Ci sono gli adulti, ex adolescenti, che quel male lo recidivano e ci fanno i conti dalla scuola all’università fino al posto di lavoro e poi in famiglia. Malattie psichiatriche che tolgono affetti, concentrazione, condivisione di attimi di gioia; anoressia, bulimia, binge eating sono streghe mascherate che fanno breccia nelle fragilità umane e si insinuano nel luogo più caldo del nostro essere: la relazione, il cibo che dà sostentamento e vita. Il cibo vissuto come nemico, alleato, conforto, punizione. Malattie che trasformano mente e corpo, che uccidono la sessualità, la fisicità delle relazioni e dell’essere presente nel qui e ora. Malattie che chiamano malattie: disturbi gastrici, ossei, ginecologici, endocrinologici e che inducono comportamenti autolesionistici che affiorano da quel dolore interiore, quel male oscuro del vivere insopportabile in età adulta, figuriamoci quando si insinua nel corpo di un bambino che, a un certo punto, decide di non mangiare più.
Il grande lavoro di sensibilità e di denuncia fatto dalle tante associazioni sul territorio è molto spesso l’impulso che congiunge i bisogni del malato alla politica alla sanità, che dovrebbero dialogare affinché ci possa essere un’adeguata presa di coscienza del problema e un concreto impegno per la sua soluzione. Ma rappresenta anche il coraggioso impegno di chi affianca la Sanità pubblica laddove non si arriva a intercettare il male e a indirizzarlo sulla via giusta per trovarne cura. Ammesso e non concesso che la cura sia disponibile. Il paradosso sta proprio in questo: la prevenzione, specie quella primaria, dovrebbe riconoscere eventuali sintomi, comprendere comportamenti anomali nei confronti del cibo o nel rapporto con specchio e bilancia che si possono instaurare nei ragazzi e nelle ragazze, che molte volte restano lì, fluttuando in modo quasi border tra la normalità e il disagio. Se questi sintomi vengono intercettati, se il male slatentizza e se c’è bisogno di cura, che si fa? Si entra in un girone dantesco fatto di rimpalli di competenze troppo spesso non adeguate, di attese. Di dolore.
La situazione in Piemonte
La giornata del 15 marzo è stata occasione per sottolineare quanto si potrebbe fare e quanto non si fa in Piemonte, e quanto si era detto che si sarebbe fatto e non si è fatto. Nel luglio 2022 è stata approvata all’unanimità la legge 10 con cui la Regione si è dotata di proprie “Disposizioni per la prevenzione e la cura dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione (DNA) e per il sostegno ai pazienti e alle loro famiglie”. La norma trovava copertura finanziaria nella quota del fondo nazionale destinata al Piemonte e prevedeva azioni e progetti concreti per contrastare questa situazione, fondo che poi è stato cancellato dai tagli del Governo e che, come alternativa, aveva avuto l’impegno del ministro Schillaci per un fondo di 10 milioni di euro destinato alla cura e alla prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare e 32 prestazioni previste nei Lea (Livelli essenziali di assistenza), di cui 16 a partire dal primo aprile scorso ed altre 16 da inserire con un successivo aggiornamento.
Dietro l'angolo, però la beffa: infatti, con l’entrata in vigore del nuovo nomenclatore, non solo il fondo nazionale nel passaggio dei DCA all’interno dei LEA è stato ridimensionato, ma l’assistenza sanitaria pubblica ha escluso le visite dietologiche. Va da sé il domandarsi se chi scrive le norme sappia cosa sta normando e se applichi un po’ di buon senso. Toglierle dalle prestazioni garantite ha il sapore di un’amara impreparazione mista a superficialità. Inoltre, dal 2019, il Centro per la cura dei disturbi alimentari di Lanzo (ASL TO4), ritenuto di riferimento regionale, ha subito tagli ripetuti al personale e depotenziamento culminato con la chiusura del Day Hospital.
C’è poi la cronaca: nel dicembre scorso, due ragazze ricoverate all'ospedale Molinette di Torino a causa di disturbi alimentari furono aggredite e violentate nel reparto di psichiatria. Un fatto che ha testimoniato drammaticamente l’incompatibilità di quell’ambiente alle esigenze di cura, riservatezza e accoglienza dei pazienti affetti da questo genere di malattia, e che più volte negli anni è stato sottolineato da medici, associazioni di famigliari di pazienti e dai pazienti stessi. Tutto questo con buona pace del “Codice lilla” previsto dalla stessa legge e a livello nazionale, che vorrebbe una sorta di corsia preferenziale di presa in carico “dedicata” del paziente che giunge in pronto soccorso con sintomi riconducibili a disturbi del comportamento alimentare. Ad oggi, in Torino i posti letto destinati a questo tipo di problemi risultano essere solo sette.
Da anni viene sottolineato il bisogno negli ospedali hub di posti letto separati e dedicati e, sul territorio, di percorsi specifici all’interno dei CSM; oltre alla necessità di una struttura residenziale pubblica o convenzionata, ad oggi del tutto assente sul territorio regionale.
Eppure, a leggere il testo della legge, così ben scritto, la Regione avrebbe dovuto “individuare le aziende sanitarie e ospedaliere, afferenti alla Rete regionale, nelle quali sono costituite unità funzionali specialistiche adibite al trattamento, anche ospedaliero, di pazienti affetti da disturbi del comportamento alimentare, nonché specifiche strutture regionali idonee” alla gestione delle emergenze.
Si legge anche della creazione di équipe integrate per i pazienti nell’età evolutiva, con psichiatra, neuropsichiatra infantile e professionisti con formazione specifica in merito ai disturbi alimentari e definizione di percorsi per la transizione, concordata tra relative équipe, dai servizi per i minori ai servizi per gli adulti, quest’ultimo un nervo scoperto estremamente doloroso per pazienti e famiglie.
Un adolescente che sceglie di mettersi nelle mani dei medici per uscire dal giogo dell’anoressia, della bulimia o dell’obesità grave da alimentazione incontrollata lo fa dopo molta diffidenza, spesso ritrosia. Per questo genere di malati è difficile affidarsi e quando lo fanno è importante poter considerare la fiducia che si instaura tra loro e i medici come una grande conquista sulla quale costruire la guarigione. Ad oggi però, il paziente, giunto alla maggiore età passa dai percorsi nelle strutture pediatriche al sistema territoriale. Con le ripercussioni sul percorso di cura facilmente intuibili.
Continuano a mancare drammaticamente strutture e contesti di cura con specifici percorsi e interventi ambulatoriali per l'intercettazione precoce, la diagnosi, il trattamento e l'eventuale invio dei pazienti alle strutture più appropriate della Rete regionale. Manca la formazione dei medici, soprattutto quelli di famiglia.
Per di più l’Osservatorio che avrebbe dovuto monitorare l’effettiva realtà territoriale del problema, si è riunito non più di un paio di volte.
Insomma, ancora una volta, le parole della retorica celebrativa che danno impulso alle intenzioni altro non fanno che risuonare come sterili pacche sulla spalle del dolore. A questo punto sembra cinico ma diventa lecito domandarsi se sia opportuno fare attenzione, autocompensandosi senza nulla chiedere.























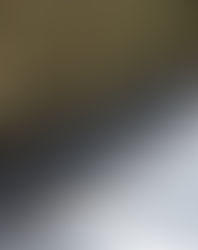





















Commenti