Carceri, la prima emergenza reale è l'ottusità di chi governa
- Guido Tallone
- 23 ago
- Tempo di lettura: 7 min
Aggiornamento: 24 ago
di Guido Tallone

Due punti di vista, due interpretazioni diverse e – di conseguenza – scelte diametralmente opposte. Niente di nuovo sotto il sole: le regole del pluralismo permettono anche questo. Ciò che è anomalo e grave è – però – il fatto che i soggetti che hanno valutato in modo contrapposto una determinata realtà appartengono alle nostre più alte Istituzioni pubbliche, quelle chiamate ad organizzare e a “gestire” la nostra convivenza.
I fatti. La dichiarazione del Ministro della Giustizia Carlo Nordio sul fatto che “non esista alcuna correlazione tra sovraffollamento e suicidi nelle carceri” ha fatto molto discutere. Ha suscitato molti commenti e – come era prevedibile – anche molte contestazioni. Anche perché con un sovraffollamento carcerario che si aggira, in media, attorno al 130 per cento con punte però che raggiungono anche il 190 e il 200 per cento (!), difficile non individuare tra le prime cause del gesto estremo da parte del detenuto anche questa disumana, inaccettabile e vergognosa condizione di promiscuità in spazi ristretti.
L'intervento del ministro della Giustizia
Ed ecco la lettura opposta: il Tribunale di sorveglianza di Torino ha interpretato in modo diverso la realtà quasi banalizzata da Nordio (“il sovraffollamento carcerario facilita la sorveglianza tra i detenuti”) e ha emesso una ordinanza per concedere la detenzione domiciliare ad un carcerato malato, anche sei in modo non grave, in virtù del sovraffollamento nel carcere del capoluogo piemontese. “Scarcerato per sovraffollamento”, hanno titolato i giornali. E si noti come si è espressa il Procuratore Generale, Lucia Musti, nell’accogliere la richiesta della difesa del detenuto-malato e nel concedere gli arresti domiciliari: “Il magistrato, sia giudice, sia pubblico ministero, deve contemperare esigenze di sicurezza e realtà territoriale e del momento storico”. Come a dire: con un sovraffollamento del 134 per cento (questa la percentuale dell’istituto penitenziario di Torino), il detenuto non può curarsi e non è più inserito in un “trattamento penitenziario” finalizzato alla sua rieducazione, ma è semplicemente immerso in un “contenitore” incaricato di esercitare la vendetta sociale come risposta al suo reato.
La decisione del magistrato non ha restituito la libertà al detenuto (anche perché gli “arresti domiciliari” sono pur sempre “detenzione”), ma ha creato, da un lato, le premesse perché il malato soggetto a restrizione della libertà possa curarsi umanamente; dall’altro lato, ha alleggerito anche il carico lavorativo della polizia penitenziaria spesso costretta a impegnativi trasferimenti in ospedale (e anche questo aspetto non è proprio periferico). In pratica, il Procuratore Generale ha riconosciuto che il carcere può causare in detenuti alle prese con patologie significative anche se non incompatibili con la detenzione, “un surplus di sofferenza e disagio evitabile con misure alternative”.
Sapendo – prosegue il Tribunale – che le valutazioni non sono mai oggettive, ma sempre e soltanto “soggettive”. Per prendere in considerazione caso per caso e per dare concreta risposta a tanti elementi significativi con i quali la detenzione deve obbligatoriamente confrontarsi: condizioni di salute del detenuto, comportamento in carcere, quanto manca al fine pena, pericolosità, tempo trascorso dal reato, etc. etc.
Non stupisce che su una determinata vicenda vi siano punti di vista diversi e opposti. L’aspetto interessante della vicenda è dato dal fatto che, ancora una volta, debbano essere “altri” a farsi carico di scelte e di indirizzi politici che chi governa non è in grado di assumere.
Suicidi dietro le sbarre: 55 dall'inizio dell'anno
Se il Ministro della Giustizia non riconosce al sovraffollamento carcerario la sua gravità e il suo essere tra le prime cause dei suicidi che avvengono “oltre il muro” (nella prima parte di quest’anno sono già 55 i detenuti che si sono tolti la vita in carcere) [1], quell’“assenza” operativa e legislativa da lui lasciata, prima o poi sarà occupata da qualche altra Istituzione (o da qualche altro soggetto) che non può ignorare un oggettivo stato di illegalità all’interno del luogo istituzionale preposto per rispondere a chi ha commesso reati e deve essere rieducato alla vita legale.
In contesto sociale – come in natura – il “vuoto” non esiste. Lo spazio lasciato libero da chi non prende le decisioni che dovrebbe, viene inevitabilmente “occupato” da altri soggetti. “Se per me non c’è posto nemmeno in carcere – dicono quanti in carcere si tolgono la vita –; se nemmeno tra gli esclusi posso trovare un minimo di posto dignitoso, allora mi tolgo di mezzo. Voi lo chiamate «sovraffollamento», ma io lo chiamo «oppressione da vissuto di insignificanza»”.
Il Tribunale di sorveglianza di Torino ha fatto altri ragionamenti, ma anche questa Istituzione ha deciso di colmare un “vuoto” – nocivo e inaccettabile – lasciato da decenni di negligenze, di promesse, di inazione e di assenze legislative.
Dovremo sentirci dire che la magistratura ha invaso il campo della politica? Credo proprio di no. Possiamo però dire che la magistratura ha ricordato alla politica e all’opinione pubblica che per quanto difficile e complesso un problema sia, lo si può sempre “governare” in modo costruttivo e positivo.
Il depotenziamento della Legge Gozzini
È dalla metà degli anni ‘70 che si parla – in Italia – del problema “carceri”. Strutture fatiscenti, sovraffollamento, carenza di personale, istituzioni chiuse e incapaci di garantire la rieducazione del recluso ed altro, tanto altro. Per non parlare poi di rivolte, evasioni, allarme sociale, amnistie, indulti o altri titoli. E ad ogni emergenza si è risposto – puntualmente – in modo emergenziale. La costruzione di nuove strutture detentive è quasi sempre stata affidata a promesse mai attuate. Vengono assunti – di tanto in tanto – nuovi e ulteriori agenti di custodia, ma anche questi “rattoppi” (doverosi e sacrosanti) non escono mai dalla logica emergenziale. Maestri, docenti, psicologi, operatori sociali, educatori…, restano – all’interno delle nostre strutture detentive – altamente insufficienti anche se sono questi profili professionali i maggiori garanti della rieducazione di chi ha commesso dei reati.
Da decenni non si riesce a “governare” questa realtà in modo organico, sistematico ed efficace. E quando dico “governare” (utilizzando il verbo per eccellenza della politica) intendo la capacità di prevedere, gestire, organizzare e pianificare una realtà che non può essere solo osservata e inseguita nei suoi cambiamenti.
“Governare” la realtà del carcere significa attuare – in modo sistematico e coraggioso – quelle riforme strutturali e profonde che sono in grado di ripensare sostanzialmente la pena detentiva. Riforme del sistema carcerario che sono state tentate nei decenni precedenti, ma che – per mille ragioni – non sono mai state completate. Quando però a metà degli anni ’80 si attuò la famosa riforma Gozzini, che prevedeva la flessibilità della pena (la possibilità di modulare e graduare la pena nel corso dell’esecuzione in modo da favorire il processo rieducativo del condannato) la condizione carceraria risentì positivamente di questi cambiamenti. Purtroppo però, con il passare del tempo, la Riforma Gozzini è stata deformata da controriforme repressive (e del tutto inutili) nonostante avesse dato ottimi risultati in termini di miglioramento della vita detentiva.
Rispetto agli anni ’90 oggi la popolazione carceraria è raddoppiata! La politica si limita a registrare il numero di detenuti che aumenta di anno in anno senza nemmeno sospettare che il compito di chi governa è quello di individuare – a priori – il numero dei detenuti che ragionevolmente possono essere accolti dalle nostre strutture detentive affinché la pena sia efficace nella sua finalità riparativa e rieducativa. E una volta raggiunto quel limite, oltre il quale non si può andare, è compito di chi “governa” il sistema penale costruire altre strategie (alternative alla detenzione) finalizzate a rispondere alla trasgressione con la giusta punizione riparativa. Per capirci: chi governa non può restare spettatore passivo del sovraffollamento carcerario. Deve creare le condizioni politiche e legislative perché quella stortura venga raddrizzata a monte.
Significa che è compito di chi governa creare le giuste alleanze (possibilmente coinvolgendo anche detenuti) per occupare quel “vuoto” che oggi i carcerati, i magistrati, molti volontari e Associazioni specifiche tentano faticosamente di colmare. E poi adoperarsi – con interventi legislativi ad hoc – affinché il carcere non resti la sola e unica risposta al mondo dei reati.
La sicurezza sociale non si fonda solo sulla detenzione
Lo hanno ripetuto per anni i profeti inascoltati: il carcere deve essere e restare l’estrema ratio del sistema penale (Carlo Maria Martini). Non si può utilizzare la detenzione come la sola e unica strada per illudersi di costruire sicurezza sociale. Diverso è il caso di chi insegue il consenso e vende “pene certe” a chi si è autoconvinto che la severità verso gli altri e il permissivismo su sé stessi rappresenti il giusto equilibrio tra egoismo, indifferenza e severità. E anche per i casi in cui non si riesce a fare a meno del carcere, questa struttura detentiva non può e non deve mai rinunciare alla sua finalità rieducativa. Ecco l’impegnativo compito a cui è chiamata la nostra Politica: riformare il nostro sistema detentivo e “governare” ciò che oggi non è governato, ma abbandonato al caos.
Difficile, certo. Ma possibile. Anche perché siamo chiamati a “rompere” il severo giudizio di Foucault, riportato nel suo celebre saggio “Sorvegliare e punire. Nascita della prigione”, Torino, 1976, in cui afferma che: “Conosciamo tutti gli inconvenienti della prigione, e come sia pericolosa quando non è inutile. E tuttavia non «vediamo» con quale altra cosa sostituirla. Essa è la detestabile soluzione, di cui non si saprebbe fare a meno›› (p. 252). Oggi – cinquant’anni dopo questo severo giudizio – alternative e percorsi sostitutivi alla detenzione in carcere ci sono e, se si vuole, si possono incrementare.
Ma perché questi piccoli sentieri diventino strade percorribili è necessario che tanto la politica quanto l’opinione pubblica si convincano che la prima risposta da attuare nei confronti di chi ha commesso un reato non è affidarlo ad un luogo in cui scontare la sua colpa possibilmente con un po’ di sofferenza (chiamandola, tra l’altro, “pena certa”!), ma creare le giuste occasioni (al plurale e durante l’intero percorso correttivo) perché chi è uscito dai canoni della legalità possa riabilitarsi.
Note















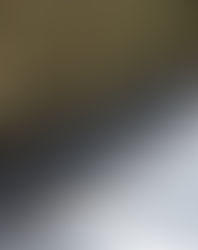





























Commenti