Viaggio nell'Italia insolita e misteriosa
- Ivano Barbiero
- 19 set 2025
- Tempo di lettura: 5 min
Aggiornamento: 20 set 2025
Alla scoperta dei tesori dell’Aquila: "La fontana delle 99 cannelle" (parte prima)
di Ivano Barbiero

Rimane in Abruzzo il nostro infaticabile viaggiatore che da Pacentro,[1] nel Parco nazionale della Maiella, si sposta di una settantina di chilometri per raggiungere L'Aquila, il capoluogo aquilano che il 6 aprile 2009 fu sconvolto da un terremoto di magnitudo 6,3 che provocò 309 morti e circa 1.600 feriti, l'abbandono delle case disastrate di decine di migliaia di persone e seri danni a edifici e al patrimonio culturale.
Oggi l'occhio di Ivano Barbiero, di cui dividiamo il racconto in due puntate (la prossima sarà pubblicata sabato prossimo), si posa sulla famosa "Fontana delle 99 cannelle", una storia quasi millenaria che "sgorga" da sorgenti misteriose...
La prima volta non si scorda mai, non fa eccezione la fontana delle 99 cannelle dell’Aquila che vidi da piccolo su un televisore in bianco e nero tra un Carosello pubblicitario e un intervallo di pecore che non finiva mai. E chissà quante persone avanti negli anni come me sono arrivate in questo luogo lontano dal centro cittadino, affascinate dai ricordi o dal rumore ipnotico e altalenante dell’acqua corrente o dalle decine di volti enigmatici e misteriosi scolpiti nella pietra. Inutile sottolineare che l’effetto piacevole è sempre immutato per questa fontana che si trova a Borgo Rivera nel capoluogo dell’Abruzzo vicina al fiume Aterno, a meno di cinquecento metri a piedi dalla stazione ferroviaria.

Nessuno può affermare con certezza quale sia il fine di quest’opera a cielo aperto realizzata nel XIII secolo, su progetto attribuito a Tancredi da Pentima (1272). Resta il fatto che da tempo immemore fa parte del patrimonio monumentale della città. Nonostante si chiami “Fontana delle 99 cannelle”, le cannelle vere più i mascheroni da cui sgorga acqua non sono necessariamente 99. Infatti, ci sono 93 mascheroni decorati. E poi sei cannelle semplici senza decorazione, spesso non funzionano come le altre. Poco conta che il numero effettivo dei castelli fondatori fosse meno di 99, la leggenda pare abbia “gonfiato” il numero e la fontana molto probabilmente sia stata modificata (con aggiunte successive) per arrivare al numero simbolico. Resta però il fascino di ogni mascherone che è stato scolpito in modo differente: visi umani con espressioni diverse, qualche volto con tratti stilizzati, altri che ostentano elementi ornamentali (capelli, barbe, copricapi). Questa varietà è simbolicamente intensa, e la gente si diverte a contarle e studiarne le diversità.

Le 6 cannelle semplici (senza mascherone) dicono che rappresentino le piaghe di Cristo. Eppoi, c’è l’ulteriore stranezza della fontana che non è rettangolare o simmetricamente perfetta: infatti ha una pianta trapezoidale, con lati su livelli e sfalsamenti, oltre ad una scalinata su un lato che guarda verso la chiesa di San Vito. Le pietre usate sono di colori alternati, tipicamente bianco e rosa, in una composizione “a scacchiera” nei rivestimenti laterali. Questo motivo è condiviso con altri monumenti della città, e alcuni storici affermano che non si tratti di un caso. C’è poi una lapide trecentesca nella struttura con iscrizione che riporta la data di inizio dei lavori (1272) e il nome di Tancredi da Pentima.

A causa delle modifiche successive, dei restauri e dei terremoti, non tutte le parti sono perfettamente uniformi. Alcuni mascheroni o fronti risentono di restauri diversi. Infine, c’è la leggenda della sorgente nascosta, poiché non è ben chiaro quale sia la fonte originale che alimenta l’acqua.
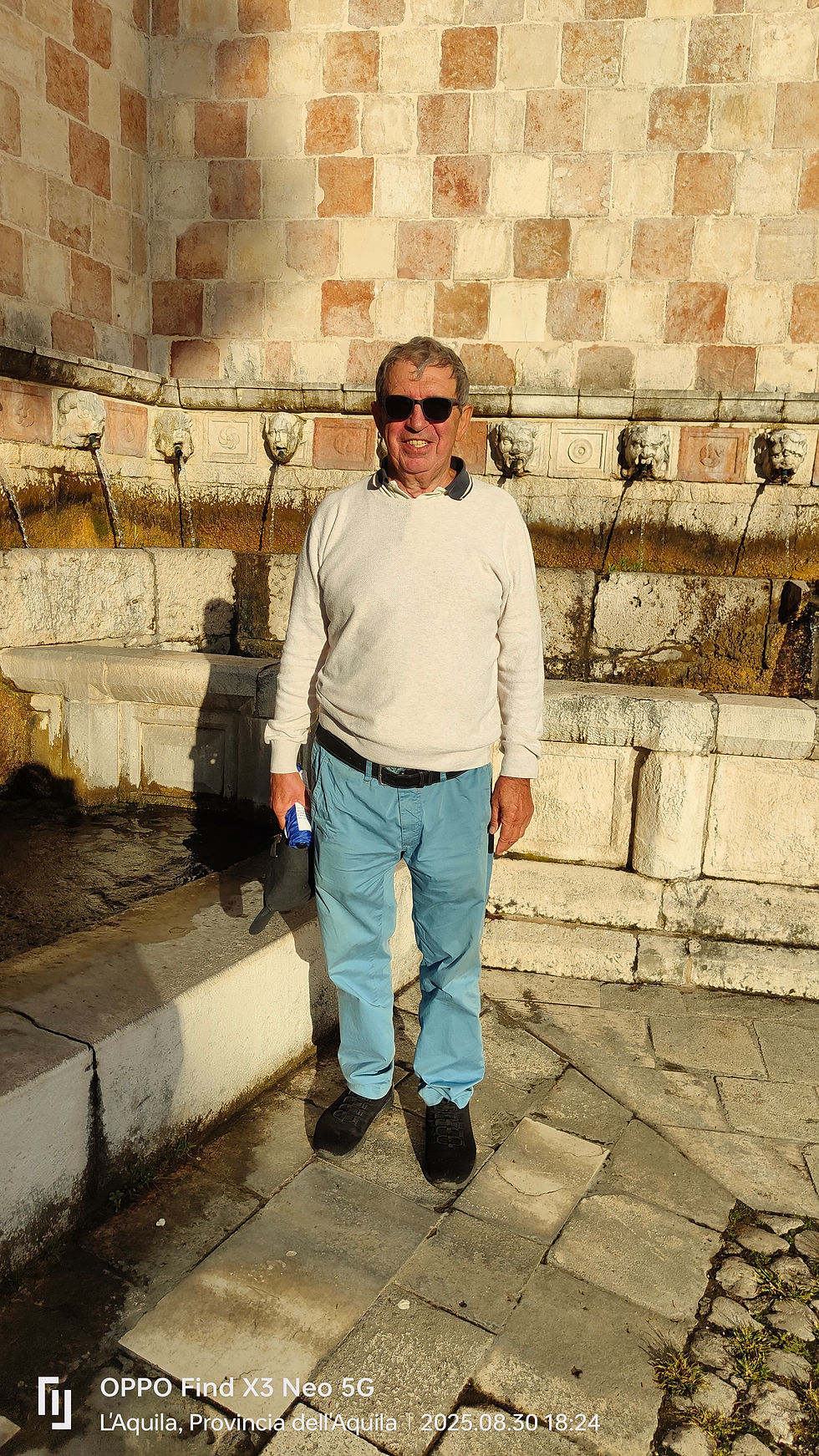
Alcune versioni dicono che sia volutamente tenuta segreta per evitare dispute tra i castelli fondatori. Si nota anche che nella parte superiore della fontana esiste un motivo a scacchiera o a blocchi alternati di pietra bianca e pietra rosa, che richiama lo stile architettonico tipico aquilano. Altro mistero: quasi tutti i mascheroni funzionano, ma in altri momenti qualche cannella è secca o non visibilmente attiva. Ciò evidenzia disuniformità nel funzionamento, differenze di portata d’acqua e di flusso tra loro.
Un mascherone particolare è quello che ha la testa di pesce (visione fantastica) che si legherebbe alla leggenda di Colapesce, o a storie medievali, come rimando a misteri antichi. Non è un volto umano ma una sorta di ibrido zoomorfo, con squame e bocca spalancata da cui esce l’acqua. È stato interpretato come un richiamo al simbolismo cristiano del pesce (Ichthys, che in greco antico significa Pesce, ma che ha un forte significato simbolico nelle origini del cristianesimo: Cristo “pescatore di anime”), non manca però la traccia di miti pagani e medievali legati a creature marine o mostri fluviali. Alcuni storici vedono in questo volto la personificazione della sorgente che alimenta la fontana, per distinguerla dagli altri 98 getti “umani”.
Alcuni di questi volti presentano corna, dentature accentuate, linguacce o ghigni deformati. In questo caso possono rimandare al repertorio medievale dei mostri apotropaici, cioè figure che allontanano il male, come le gargolle delle cattedrali; in altri casi ricordano caricature di vizi umani: gola, ira, superbia.

Alcuni hanno occhi enormi e privi di pupille, altri un’espressione neutra o quasi “assente”: potrebbero alludere alla condizione umana di fronte al divino. Alcuni sporgono poco, hanno lineamenti abbozzati o consumati, come se fossero volti non finiti o cancellati. Non sempre è effetto del tempo: in certi casi sembra voluto, per alternare volti ricchi di dettagli a quelli scarni.

Potrebbero quindi simboleggiare la fragilità o la caducità della vita, oppure i “castelli fondatori” più piccoli o meno importanti rispetto agli altri. Molti mascheroni hanno tratti quasi ritrattistici: uomini barbuti, donne velate, giovani e anziani. ognuno con il proprio volto. È però più che probabile che alcuni siano ispirati a volti reali, come notabili dell’epoca o forse persino l’architetto Tancredi da Pentima.

Fra tanti volti e visi l’attenzione viene inevitabilmente catturata dal mascherone soprannominato “La Monaca” o “Donna Velata”. È uno dei pochi mascheroni femminili riconoscibili: il volto è incorniciato da un velo o cofano, che ricorda molto un abito monacale medievale. L’acqua sgorga dalla sua bocca come per tutti gli altri, ma l’espressione è seria, composta, quasi ieratica. Alcuni storici ritengono possa raffigurare non una monaca vera e propria, ma una donna velata (moglie o matrona), dato che il velo era comune nell’abbigliamento medievale femminile. Fra tutte le possibili interpretazioni, si propende per una figura religiosa, ovvero un richiamo alla devozione o alla presenza monastica nella vita cittadina. L’Aquila, sin dal Trecento, era circondata da conventi e ordini mendicanti. Si parla anche di una Madonna simbolica: il volto velato potrebbe evocare un’allusione mariana, quasi un’iconografia sacra “nascosta” tra i mascheroni. Infine, secondo la leggenda dei 99 castelli, questo volto potrebbe rappresentare una comunità religiosa che partecipò alla fondazione della città. Questa figura contrasta con i volti grotteschi o mostruosi vicini: è infatti uno dei più sobri, come se fosse stato messo lì apposta a “bilanciare” il caos delle facce deformi.
Continua/1
Note











































Commenti