I Maggio di lotta e di progetto
- Igor Piotto
- 30 apr 2025
- Tempo di lettura: 3 min
Aggiornamento: 1 mag 2025
di Igor Piotto

La storia del lavoro è un corpo a corpo quotidiano che donne e uomini intrattengono con la forza espressa dalla volontà di potenza del profitto. Un conflitto permanente (non sempre espresso in maniera organizzata) che assume storicamente forme diversificate. Non lo si deve dimenticare oggi, 1 maggio, festa dei lavoratori.
Un insieme di fattori ha fortemente indebolito le capacità rivendicative del lavoro. Secondo l'Istat (Rapporto annuale 2024), la quota di occupati a rischio povertà passa dal 9,5% del 2010 all'11,5% del 2022, nello stesso anno il 30% dei dipendenti percepisce una bassa retribuzione annuale, in una cornice che vede le retribuzioni aumentare tra nell'intervallo temporale 2013-2023 del 16% (con una media europea del 30,8%). Il rinnovo dei contratti è riuscito a compensare parzialmente l'andamento dei bassi salari e la spinta inflattiva. Ed è da questo scenario che occorre ripartire.
Riduzione del potere d'acquisto dei salari
Da anni assistiamo ad un progressivo impoverimento della condizione lavorativa che si sviluppa nell'intreccio di deprivazione salariale, discontinuità occupazionale, progressivo incremento della vulnerabilità tanto da mettere in crisi una dicotomia particolarmente diffusa (e strumentalmente utilizzata dal pensiero neoliberista) che suddivideva il mercato del lavoro in garantiti e non (Insider/outsider); i fattori di incertezza hanno ampiamente investito segmenti del mercato del lavoro in passato al riparo da rischi di deprivazione e vulnerabilità: aumentano i rischi di incertezza per un numero sempre più ampio di occupati, ma aumentano anche le disuguaglianze salariali all'interno della composizione della forza lavoro: precarietà e della competizione tra lavoratrici e lavoratori contribuiscono ad indebolire il lavoro organizzato, nel conflitto distributivo tra capitale e lavoro. In Italia la moderazione salariale (con retribuzioni reali al di sotto del pur contenuta produttività del lavoro) ha determinato un arretramento della quota dei salari sul prodotto nazionale a fronte di un incremento dei redditi da capitale.
Tutti gli indicatori economici convergono nel descrivere una polarizzazione nella distribuzione della ricchezza: la compressione dei salari aumenta le diseguaglianze sociali, alimenta tendenze competitive tra gli occupati, disperde le possibilità della rappresentanza sindacale con ricadute sulla contrattazione collettiva. È un fenomeno che si sviluppa in una cornice di trasformazione economica globale (frammentazione dei cicli produttivi che operano su catene globali del valore, crescente diffusione di tecnologie digitali, deregolamentazione normativa del mercato del lavoro). In Italia queste tendenza trova una declinazione ulteriormente aggravata da altri fattori che collocano il fenomeno dello sfruttamento/impoverimento in un modello strutturale caratterizzato da limitati investimenti in innovazione tecnologica e organizzativa, slittamento dell'apparato produttivo su imprese di ridotte dimensioni e l'assenza di politiche economiche e industriali.
Sfruttamento = infortuni mortali sul lavoro
Il termine sfruttamento è stato espulso dalla comunicazione pubblica, ad esso si è preferito la versione edulcorata di flessibilità. L'ideologia, mai supportata da evidenze empiriche, della riduzione dei diritti come premessa necessaria alla crescita occupazionale e dei redditi non solo ha lambito le fortezze culturali della sinistra, ma alcuni custodi di questa ortodossia sono diventati consiglieri del “Principe”. Tre decenni di liberalizzazione delle norme del mercato del lavoro sono un fatto storico ineludibile: lo sfruttamento intensivo del lavoro investe il mondo del lavoro ma aggredisce con maggiore incidenza giovani, donne, lavoratori migranti. Questo pone interrogativi a tutto il movimento organizzato dei lavoro, nelle sue diverse componenti, politiche, sindacali, associative. I referendum promossi dalla Cgil su licenziamenti, precarietà e regolazione del sistema degli appalti e il quesito referendario sulla cittadinanza, rappresentano il tentativo di aprire una crepa in questa logica di accumulazione che mina le basi della coesione sociale e determina una crescente sofferenza sociale. Oltre 1000 morti sul lavoro solo nel 2024 sono parte di questa logica: lo sfruttamento correlato all'attuale regolazione del mercato del lavoro è una forma di violenza considerata legittima.
La spinta referendaria (proprio per la sua connotazione abrogativa) necessita di una fase progettuale che non può risolversi nella riproposizione delle “strategie di tamponamento”, quelle che vedevano la sinistra apportare miglioramenti ad un paradigma economico di matrice neoliberista assunto come immutabile e inamovibile. La scelta delle opposizioni parlamentari di promuovere un disegno di legge sul salario minimo è un passaggio importante. Occorre proseguire nella elaborazione di una visione dello sviluppo, sostenuto da una solida teorica economica, su cui aggregare un blocco sociale che assuma l'ambizioso obiettivo di ritrovare nel soggetto pubblico di uno “Stato innovatore” (per utilizzare l'espressione di Mazzucato) l'asse di un governo dell'economia. È l'autonomia della politica, alternativa alla subalternità all'economia, capace di dare un'idea collettiva di futuro e sottrarre i ceti subalterni dalle maglie di un individualismo difensivo di rabbia e sofferenza. Il fascino sovranista sui ceti popolari si combatte con una nuova idea di socialità. Forse anche di socialismo.











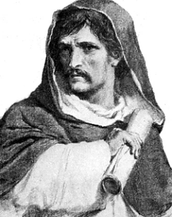






















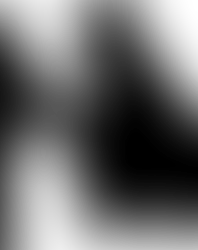







Commenti