I Cattolici alessandrini tra Regime fascista e Resistenza
- Alberto Ballerino
- 20 set
- Tempo di lettura: 4 min
Aggiornamento: 21 set
Due giornate di studio nel capoluogo per gli 850 anni della Diocesi
di Alberto Ballerino

“Cattolici e società ad Alessandria tra fascismo e guerra, resistenza e liberazione” è il titolo dell’iniziativa che si articola in due giornate presso la Sala Iris del Collegio Santa Chiara in via Volturno 18: la prima si è svolta ieri, sabato 20 settembre [1], la prossima tra sette giorni. Al Convegno ha partecipato con una relazione, Alberto Ballerino, da mesi uno dei principali collaboratori de La Porta di Vetro, che ha analizzato il fenomeno dell'antisemitismo ad Alessandria negli anni Trenta, di cui l'autore riporta alcuni passaggi all'interno della cronaca della giornata.
Quale ruolo ha avuto il mondo cattolico negli anni del fascismo e della Resistenza? Ad Alessandria si è deciso di indagare questo aspetto in ambito locale con un grande convegno organizzato in occasione delle celebrazioni per gli 850 anni dalla fondazione della Diocesi. Anima dell’iniziativa è stato don Stefano Tessaglia che ha saputo costruire un evento di grande interesse, coinvolgendo numerosi e qualificati studiosi, e che ha ricevuto i ringraziamenti per come ha saputo raccontare un pezzo importante degli 850 anni della Diocesi dal Vescovo di Alessandria, Monsignor Guido Gallese. "Questo convegno rappresenta un momento importante perché ci ricorda quanto sia necessario approfondire la storia contemporanea in tutti i suoi aspetti - ha detto in proposito il presule - senza trascurare il ruolo dei cattolici, che è stato fondamentale. La prima giornata sarà dedicata al tema dei cattolici nel ventennio e durante la guerra, mentre la seconda affronterà la fase conclusiva di quel periodo, con particolare attenzione alla resistenza e alla liberazione". Ieri si è affrontato il tema Alessandria: fascismo e guerra dedicata al rapporto tra cattolici e dittatura. Si è trattato della vita religiosa e sociale durante il Ventennio nero, dei riflessi delle politiche del regime sulla comunità locale, del tema dell’antisemitismo e della memoria materiale e culturale di quegli anni. Sono intervenuti Alberto Guasco, Vittorio Rapetti, Roberto Livraghi, Agostino Pietrasanta, Andrea Villa e Francesca Lupo.

Sabato 27 settembre la giornata avrà come filo conduttore Alessandria: resistenza e liberazione, concentrandosi sulla resistenza dei cattolici piemontesi, sul contributo locale al movimento partigiano e su alcune figure emblematiche. Parleranno Alessandro Santagata, Luca Rolandi, Cesare Panizza, Patrizia Nosengo, Barbara Viscardi, Cesare Manganelli, Andrea Spagni e Giancarlo Subbrero.
L'antisemitismo ad Alessandria negli anni Trenta
Il fenomeno si collocò come alieno alla società alessandrina, dove gli ebrei si erano integrati da tempo, trovando i suoi principali alfieri nei giovani intellettuali dei Guf (Gruppi Universitari Fascisti), cui veniva dato ampio spazio su Il Corriere di Alessandria, giornale provinciale del Partito Nazionale Fascista. Aderire all’antisemitismo significava compiere una scelta di carattere rivoluzionario oltre che a operare una rottura definitiva con il vecchio ordine e con la tradizione moderata a cattolica. Era questa la posizione che sul giornale veniva proposta già il 19 ottobre 1934 da Piero Ravasenga, secondo cui il razzismo “vertendo alla Potenza, è cento volte preferibile a quelli che identificano l’Italia con San Francesco, Gioberti e Manzoni”.
L’intellettuale monferrino faceva parte del gruppo di una delle più importanti riviste giovanili di questi anni, L’Universale di Berto Ricci, tra le poche rispetto alle altre pubblicazioni coetanee, ad accogliere con entusiasmo la vittoria nazista in Germania. Berto Ricci non aveva mancato in più occasioni di esprimere sentimenti antisemiti. L’attacco agli ebrei al momento però non era ancora all’ordine del giorno.

Anzi, con l’assassinio nel 1934 dell'austriaco cancelliere cattolico Engelbert Dollfuss (foto a lato), anche il Corriere di Alessandria, come il resto della stampa di regime, si lanciava con veemenza contro il razzismo nazista.
Pochi anni dopo però, il 15 ottobre 1937 Ravasenga ritornava sul tema con un intervento che aveva un carattere ora organico e programmatico, al quale il giornale dava un particolare rilievo pubblicandolo in prima pagina. L’intellettuale monferrino individuava proprio nel razzismo e nella sua ‘modernità’ lo spartiacque definitivo tra le ‘vecchie’ democrazie liberali e i nuovi stati ‘rivoluzionari’ di destra.
La lunga campagna antisemita del Corriere iniziava l’anno successivo e aveva per protagonista il responsabile della sezione culturale del Guf, Gabriele De Rosa, che poi pubblicò anche un volume dal titolo La rivincita di Ario. Come è ben illustrato nell’articolo pubblicato il 28 febbraio 1939, la posizione del giovane intellettuale si rifaceva al razzismo spirituale lanciato dall'allora ministro dell'Istruzione Giuseppe Bottai che tentava di unire al fattore biologico di marca nazista quello legato alla tradizione e alla cultura italiana. L’antisemitismo aveva sempre un valore di rottura rivoluzionaria, ma non nei confronti della tradizione cristiana. Anzi, nel numero precedente del 26 agosto 1938, De Rosa attaccò la Chiesa per l’atteggiamento critico assunto verso la svolta razzista del Regime, cercando invano di dimostrare come la campagna contro gli ebrei fosse funzionale alla lotta contro la decristianizzazione della società moderna.

Il radicalismo e le convinzioni di questi giovani erano però destinati a infrangersi contro il vero obiettivo del Regime. Gli studenti furono tra i pochissimi ad accogliere con fiducia la guerra. Il conflitto sembrava offrire l’opportunità di mettersi alla prova, l’occasione per forgiare una nuova classe dirigente autenticamente fascista. Ma la grande potenza militare esaltata dalla propaganda di Mussolini non esisteva o, si era in parte consumata sui campi di battaglia nella guerra civile spagnola a fianco del generalissimo Francisco Franco. Lo stesso De Rosa, tra l'altro, denunciò coraggiosamente al Guf di Alessandria l’impreparazione e la superficialità con cui era stata condotta la guerra, come ricordato nei loro scritti da giovani dell’epoca, in primis Delmo Maestri e Carlo Gilardenghi.
Poche generazioni furono così brutalmente ingannate. Era iniziato un lungo calvario nel corso del quale in molti le convinzioni inculcate dall’indottrinamento crollarono, portandoli alla scelta antifascista e all’adesione alla Resistenza. Sfogliando la pagina dei giovani sul Corriere si possono incontrare i nomi di gran parte dei protagonisti della vita politica, culturale ed economica dell’Alessandria del dopoguerra e anche degli anni successivi. Da questa generazione ingannata, derubata della sua giovinezza e colpita da tanti lutti, sarebbe però emersa la classe dirigente di una nuova democrazia.
Note
[1] Il convegno, voluto dalla Diocesi e dalla Città di Alessandria, è stato reso possibile grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, con la collaborazione della Regione Piemonte, dell’Università del Piemonte Orientale, della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Alessandria, Asti e Cuneo, dell’Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea in Provincia di Alessandria, della Società di storia, arte e archeologia per le Province di Alessandria e Asti e di altre realtà culturali.









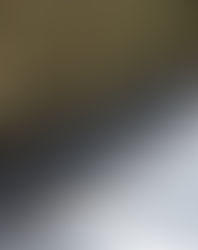



































Commenti