Distante dalla chiesa, vicina alla fede, il mondo di Marina Jarre
- Piera Egidi Bouchard
- 18 set 2025
- Tempo di lettura: 4 min
Aggiornamento: 19 set 2025
Un convegno dell'Istoreto celebra il centenario dalla nascita della scrittrice
di Piera Egidi Bouchard
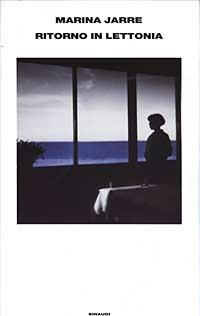
Una vita complessa e una personalità complessa, quella di Marina Jarre, certamente la più importante scrittrice valdese, dopo la generazione di Piero Jahier. Valdese di appartenenza e forse di fede – che però era segreta e interiore, essendo lei distante dall’istituzione-chiesa - : lo fu da parte di madre, Clara Coïsson, ma ebbe il padre ebreo lettone, Samuel Gersoni, che scrisse in una sua ultima straziante lettera alle figlie "ricordatevi che anche voi siete ebree".
Un’infanzia travagliata, segnata dalla crisi del matrimonio dei genitori, quando a dieci anni viene rapita da Riga, dove era nata, dalla madre, che fugge in Italia portando con sé a Torre Pellice le due figlie. Lì viene affidata alla nonna materna, e sperimenta una rigida educazione calvinista. Questo aspetto la renderà diffidente verso la cultura valdese, pur amandone il popolo e la storia, che studierà per esempio e ricreerà in vecchiaia nel libro “Neve in val d’Angrogna”. Ripercorrerà la sua biografia ne “I padri lontani”, il suo capolavoro, così come il ricordo del padre - fucilato dai nazisti nel 1941, insieme all’ultima figlia, una bambina avuta successivamente - in “Ritorno in Lettonia”, anche questo un libro intensissimo.
Ho recensito e presentato molte delle sue opere, a partire da “I padri lontani”, del 1987, quando entrai in rapporto con lei per la storia che narra delle sue radici valdesi, e diventammo amiche, condividendo anche un aspetto letterario: a lei devo la prefazione del mio romanzo “Vent’anni appena- Diario di una generazione onnipotente”- che attraversa il periodo del ’68- e la prefazione alle mie poesie “ eretiche” “L’anno di Saturno”: solo lei poteva farlo. Aveva verso di me una tenerezza indulgente, e protettiva, lei che era così critica, come se intuisse la fatica di tenere insieme la letteratura, che esige assoluta libertà, e la teologia e la chiesa, che mette le barriere implicite della responsabilità e delle regole. Lei aveva scelto la libertà della letteratura, ma era consapevole delle contraddizioni con l’ educazione delle sue origini.
Fu autrice di diversi racconti e romanzi, il più imponente dei quali è “Ascanio e Margherita”, che io nella mia recensione di allora per “Riforma” definii “ i Promessi sposi valdese”, e lei, così critica con se stessa e con gli altri, non se ne ebbe a male, anzi: ci aveva lavorato così tanto... Perché Marina intesseva la cornice di molti suoi libri situati nella storia, di una minuziosa ricerca.
Ma scrisse anche anche testi più “leggeri”, soprattutto nella prima parte della sua vita, in particolare è il bellissimo “Negli occhi di una ragazza”, in cui percorre l’ambiente di una Torino degli anni Sessanta, dove cresce questa ragazzina di tredici anni, Maria Cristina, che sembra potersi esprimere solo con il disegno, e che sperimenterà la condizione femminile del destino domestico, a cui riuscirà a ribellarsi: un vero e proprio “romanzo di formazione”, nel quale l’autrice veicola molto della sua interiorità, la difficoltà ad esprimersi nei rapporti, la solitudine che trova un appiglio solo nella creatività.
Eppure Marina è riuscita a vivere una vita piena e realizzata: il matrimonio con Gianni Jarre, quattro figli, l’insegnamento, tanti libri, almeno sedici titoli, con editori importanti, come Einaudi e Bollati: anche un premio, il Grinzane Cavour, nel 2004, per il romanzo “Ritorno in Lettonia”. Negli ultimi anni e dopo la morte molte sue opere sono state tradotte e diffuse in varie lingue. Il suo archivio, insieme a quello del marito, della madre Clara Coïsson e della sorella Annalisa Gersoni, tutti coinvolti in vario modo nelle vicende della Resistenza, è stato donato dai figli all’Istoreto, che martedì 23 settembre - nel centenario dalla nascita - ha promosso un convegno letterario dal significativo titolo “In direzione ostinata e contraria”, impreziosito anche da testimonianze di amici.
Marina, infatti, ebbe il dono dell’amicizia, nei più vari ambienti, da cui potè avere e dare affetti e condivisione. Fu affiancata, per esempio, dalla splendida attrice valdese Gisella Bein, interprete di elezione nelle rappresentazioni teatrali di “Fuochi”, e poi negli anni, di tante letture pubbliche nelle biblioteche. Condivise vacanze e momenti conviviali con amici come Gabriella e Fausto Amodei (mentre scrivo ho la notizia dolorosa che è mancato: un grande artista e una bellissima persona)[1], Rosanna Tassinari, Silvana Ranzato, ciascuno dei quali aveva anche una casa alle Valli nel cui giardino potersi ritrovare con ancora altri amici, e anche Giorgio Bouchard - con il quale lei aveva condiviso l’”Unione giovanile “ valdese - ed eravamo invitati.
Lontana dai circoli letterari o dalle chiese, Marina si può dire che apparteneva solo a se stessa, e alla sua creatività. Ma quei “padri lontani”, il padre biologico ebreo, e il mondo valdese, che aveva ricreato attraverso la loro storia, proprio attraverso di essa l’avevano coinvolta, in particolare quegli antichi montanari valdesi, che lei amava pur non sentendo di appartenervi, e di cui scriveva in una delle ultime più belle pagine della sua “autobiografia” che: "attraverso le donne mi hanno raggiunta camminando per la pietraia e mi hanno consegnato i frammenti rocciosi della loro eredità, la barbettaggine bastarda e infedele discesa nei secoli dagli antenati...".













































Commenti