L'estate al Ferrante Aporti: se il carcere minorile diventa l'unica soluzione
- Elena Apollonio
- 25 lug 2024
- Tempo di lettura: 4 min
Aggiornamento: 26 lug 2024
di Elena Apollonio*

Sono tornata per la seconda volta in meno di un anno al Carcere minorile di Torino Ferrante Aporti con l’onorevole Paolo Ciani e Piergiacomo Baroni e Erio Ambrosino, consiglieri comunali DemoS a Novara e Cuneo. Oggi sono 53 i ragazzi detenuti, 10 in più della capienza massima, quasi tutti minori non accompagnati. Il caldo è feroce e quasi tutte le attività sono sospese durante il periodo estivo. Che ci siano ragazzi, poco più che bambini, dietro alle sbarre è una cosa che fa male dentro perché è la rappresentazione più drammatica di quanto la società educante abbia fallito e continui a fallire. E’ la dimostrazione di quanto sia inadeguato e carente il sistema che dovrebbe garantire a tutte e tutti pari opportunità indipendentemente dall’essere nati in luoghi del mondo o in situazioni più o meno fortunate.
Lo Stato italiano ha ritenuto di rispondere all’aumento della delinquenza minorile con il Decreto legge 2023 n. 123 noto come Decreto Caivano figlio di una logica repressiva e punitiva. Per contrastare i fenomeni delle baby gang e l’abbandono scolastico, è stato introdotto un inasprimento delle sanzioni nei casi di spaccio e l’arresto in flagranza, fattore che ha ha riempito le carceri minorili. I ragazzi che sono al Ferrante Aporti nella maggior parte dei casi non hanno nessuno fuori a aspettarli perché le comunità educanti sono pochissime. Per questo motivo oggi c’è il pericolo che il sistema carcerario per i minori, anziché essere abolito, torni a essere considerato l’unico rimedio a situazioni di grave disagio giovanile.
Guardare all’Europa e provare a comprendere dove si colloca il sistema di giustizia minorile italiano risulta essere un’operazione più che mai utile. Leggendo i dati di una recente indagine dell'Associazione Antigone è interessante notare come la maggiore età da un punto di vista penale si raggiunga al compimento dei 18 anni in molti paesi europei.
Nel caso italiano, quest’ultima si raggiunge con i 14 anni; lo stesso accade anche in Bulgaria, Cipro e Germania. A Cipro un minore di 14 anni che ha commesso un reato può essere unicamente posto sotto la supervisione dei servizi sociali; solo dai 14 anni in su può essere anche sottoposto alla reclusione. Il sistema tedesco, invece, prevede una responsabilità penale “limitata” per i minori tra i 14 e i 18 anni, mentre la responsabilità penale “assoluta” – sempre all’interno del sistema penale per minorenni – riguarda i giovani adulti tra i 18 e i 21 anni.In Francia, nonostante l’età della piena responsabilità penale si raggiunga con il compimento dei 18 anni, i minori possono essere considerati penalmente responsabili se il giudice ritiene che abbiano una maturità sufficiente per comprendere la natura dell’atto commesso.
In Grecia e in Svezia la minore età dal punto di vista penale si raggiunge con il compimento dei 15 anni. Se nel Paese scandinavo, a partire dai 15 anni, un minore è in linea di principio trattato come un adulto, nell'altro, i soggetti di età compresa tra i 15 e i 18 anni hanno una responsabilità penale relativa.
In Spagna e Portogallo la responsabilità penale minima comincia con i 16 anni. Per i minori tra i 12 e i 16 anni che commettono atti classificati dalla legge come penalmente rilevanti viene adottato un approccio prettamente educativo e comunque la reclusione – prevista solo in casi estremi – avviene sempre presso strutture educative.
Rispetto all’utilizzo della pena privativa della libertà nei confronti dei minori inseriti nel circuito penale nei vari Stati emerge un quadro variegato a livello europeo. Sebbene per i minori la reclusione – e il regime di vita che ne consegue – venga tendenzialmente presentata come una misura assolutamente residuale, nella prassi si registra una tendenza differente. In Italia si registra un considerevole aumento nell’ultimo anno.In Bulgaria i minori condannati alla pena della reclusione in carcere vengono collocati nei riformatori, strutture relativamente autonome annesse alle carceri per adulti.In Germania, solamente percentuali residuali dei minori entrano nel circuito penale. In Grecia i minori detenuti vengono collocati in tre differenti strutture in base all’età.
La Direttiva 2016/800 fissa dei principi e delle garanzie fondamentali per il minore, tra cui il diritto ad essere informato sulle caratteristiche del procedimento a cui è sottoposto, sin dalle sue prime fasi, con un linguaggio comprensibile e per il più possibile semplificato ed adattato all’età del minorenne (art.4). L’art. 6 sancisce il diritto del minore ad essere assistito da un difensore: il minore ha il diritto di parlare con un legale senza ritardo, in ogni caso prima di essere sottoposto ad un interrogatorio, immediatamente in caso di privazione della libertà e anche prima di comparire davanti a un giudice. L’art. 7 si occupa del diritto all’individualizzazione nella trattazione del caso; i bisogni specifici del minore quali l’educazione, la protezione, la formazione, lo studio e l’integrazione sociale devono essere garantiti partendo da una valutazione individualizzata della situazione specifica del minore.
Un’altra questione che è stata rilevata da Antigone riguarda la mancanza di formazione specializzata degli operatori della giustizia minorile, soprattutto degli agenti di polizia, delle autorità giudiziarie e degli avvocati difensori.
Anche alla luce dei dati riportati, l’impegno della politica deve essere nella direzione di rendere il carcere una risorsa assolutamente residuale perché disumanizzante e spesso inutile.
*Segretaria regionale DemoS (Democrazia solidale), Consigliera comunale DemoS a Torino
















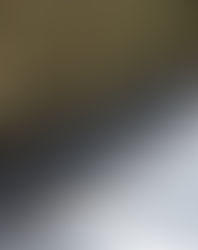





























Commenti